Si fa risalire l’origine del genere Solarpunk ad alcuni articoli programmatici e post su blog e Tumblr (una storia più completa qui). In generale, si ritiene che sia nato più come un progetto estetico-politico che come etichetta attribuita a posteriori ad alcune opere di scrittor3 e illustratric3 contemporane3. È senz’altro vero, ma è anche vero che, nel progettare la narrazione Solarpunk, si guarda volentieri ad altre narrazioni del passato (spesso ma non sempre riconducibili all’utopia). Per questo ho deciso di leggere Ecotopia di Ernest Callenbach, un romanzo statunitense del 1975, oggi considerato a suo modo un precursore del genere Solarpunk.
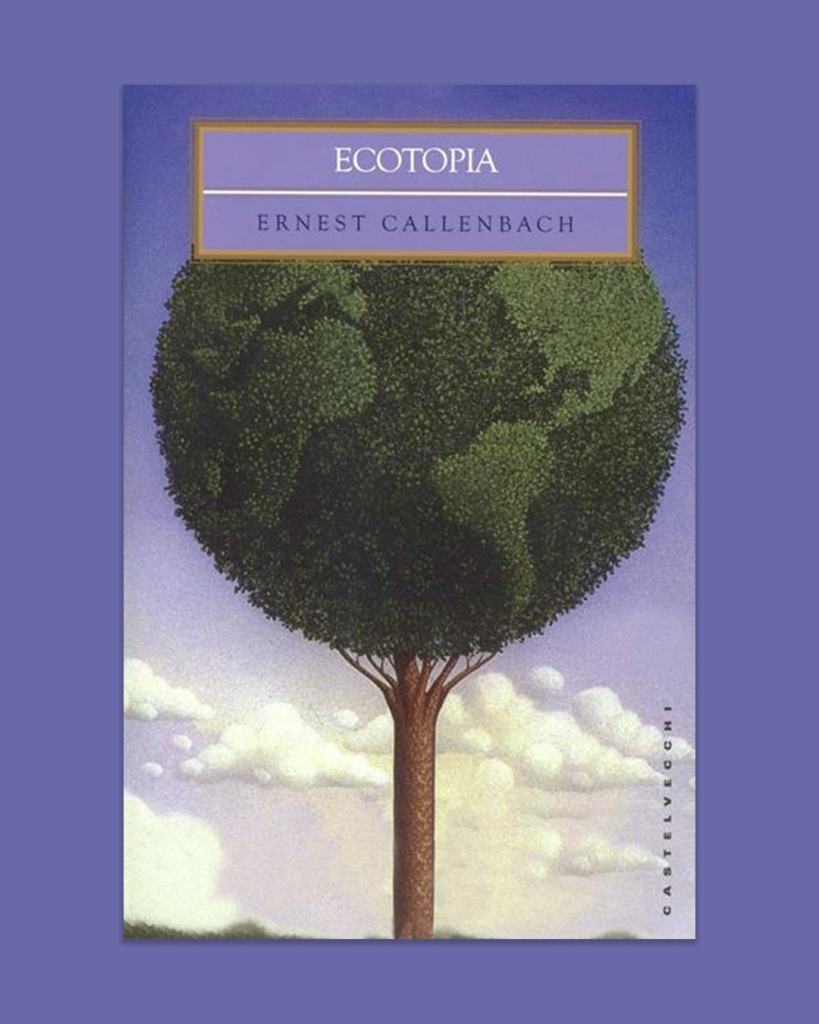
Il dispositivo narrativo è questo: dopo che una parte degli stati della costa occidentale degli Stati Uniti hanno portato a termine una sorta di rivoluzione ecologista, sono diventati indipendenti e non intrattengono più rapporti con i restanti Stati Uniti. Diversi anni dopo l’indipendenza, nel 1999, a un giornalista statunitense è concesso di andare a visitare l’Ecotopia e scrivere una serie di reportage di viaggio sui più disparati aspetti della società ecotopiana da pubblicare sui giornali nel suo paese. Il libro quindi alterna questi reportage con i diari personali che il nostro giornalista compila durante il suo soggiorno nell’Ecotopia.
La prima cosa di cui prendere atto è che Ecotopia è un romanzo invecchiato male, e per diverse ragioni. Il senso della Guerra fredda è molto presente, tra le righe, e forse al momento dell’uscita contribuiva a dipingere l’Ecotopia come l’ospite inquietante del Nord America. In effetti, pur non essendo esplicitamente socialista, lo stato ecotopiano opera una centralizzazione e una razionalizzazione motivata dall’imperativo ecologico. Allo stesso tempo però, fuori dalla descrizione strutturale, produttiva e amministrativa, i modelli di presa delle decisioni tra le persone assomigliano più a quelli assembleari dei consigli operai o del sindacalismo anarchico. Resta comunque vivo (e problematico) il fatto che la scelta ecologica sia dipinta come una scelta politica innanzitutto statale (sebbene lo stato abbia un aspetto più informale e democratico), e in secondo luogo una scelta etica della coscienza individuale, sempre in allerta e consapevole delle conseguenze delle proprie azioni sugli ecosistemi. Questi ecotopiani sono insomma una sorta di hippy, simpatici ma qualche volta un po’ zuccherosi, e sicuramente più verosimili negli anni Settanta che oggi.
Secondo punto, che nella lettura del romanzo è forse il più evidente. Come ho detto, l’Ecotopia non è strettamente socialista, anzi: c’è un sacco di capitalismo e di fiducia della concorrenza. E c’è, per erosione degli altri mercati, proprio in quei settori primari che oggi consideriamo “economia fondamentale”, come l’istruzione e la sanità. Il tema della giustizia sociale, ostinatamente presente in alcuni frangenti della vita ecotopiana, è completamente assente da altri. La caccia è praticata come svago nel tempo libero e come tradizione, il tema etico qui è completamente assente. Lo stesso vale per una certa visione delle donne, che sono continuamente valutate e sessualizzate dal nostro protagonista; la loro libertà sessuale è vista un po’ come un parco giochi per lo statunitense bianco borghese (visione senz’altro accurata, ma oggi ampiamente ricusabile, e che forse non includeremmo in un’utopia senza una minima critica riflessiva).
Arrivo all’ultimo punto: ciò che di interessante, per certi aspetti visionario, c’è in questo romanzo. Quando il nostro protagonista va all’ufficio telegrafico, si rende conto innanzitutto che la gente lavora poco e con calma; la vita quotidiana delle persone è profondamente diversa da quella degli statunitensi, e non solo per via dei vestiti bizzarri e della raccolta differenziata. La vita sembra essere perlopiù una questione al presente.
Ma di più, il nostro protagonista scopre che la gente qui tende a non avere alcun rispetto per i ruoli sociali. Capita che il telegrafista, leggendo gli articoli che gli detta, gli chieda della sua vita e delle sue opinioni. Capita che la gente si metta a discutere al ristorante e poi, in pieno spirito di autogestione, lasci il proprio ruolo di cliente pagante e si metta a consolare o ad aiutare la cuoca che ha una mole eccessiva di lavoro.
La rottura dei ruoli, per arrivare sempre a un livello più profondo del dialogo, più umano, porta con sé degli inconvenienti, come il fatto che le persone litigano più facilmente e lo esprimono senza remore. O il fatto che, proprio come succede al povero David Sedaris, questa vicinanza, così all’improvviso, può essere spaventosa. Chi non se la aspetta, come il nostro protagonista, tende a prenderti per ficcanaso o per imbecille, prima di sbottonarsi e raccontare la storia della sua vita — o di mandarti a fare in culo. Ma per come la vedo io questo atteggiamento, in Sedaris come nell’Ecotopia, è quanto di più queer posso immaginarmi da un mondo utopico, ed è esso stesso, matrice e frutto di una rivoluzione.


